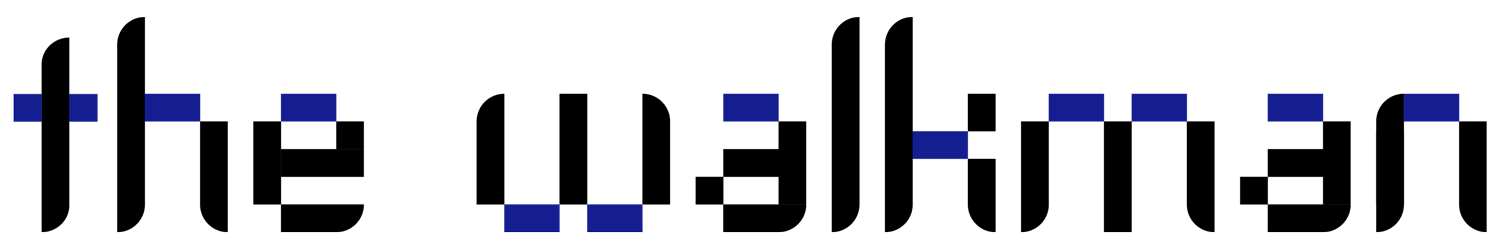Gli scacchi a me annoiano.
Ma sapete cosa non mi annoia mai? Una protagonista.
Ho sempre avuto una connessione maggiore con le protagoniste rispetto i protagonisti.
Nel percorso dell’eroina femminile sullo schermo ho sempre percepito delle sfaccettature emotive con cui empatizzare di più rispetto il viaggio dell’eroe maschile.
E no, non è perché le femmine sono più emotive dei maschi, quello stereotipo lo lasciamo alle chiacchiere da bar.
The Queen’s Gambit (da noi La Regina degli Scacchi) – miniserie Netflix di sette episodi al primo posto nella classifica dei più visti di Novembre –
ha al centro una protagonista femminile che gioca a scacchi.

È la storia della caduta e ascesa di Elizabeth Harmon, cresciuta in un orfanotrofio, dove impara a giocare a scacchi insieme al custode
e da lì in poi non si fermerà mai, diventando campionessa mondiale.
Beth è una donna che arriva prima in uno sport composto da uomini, nell’America degli anni ’50:
dal primo al settimo episodio, cade quasi sempre in piedi, e gli uomini che incontra se sorvoliamo tre o quattro commentini sotto i baffi,
la supportano, esortano, e si complimentano con lei anche una volta battuti.
Forse è anche per questo che in tantə hanno amato The Queen’s Gambit:
è rassicurante vedere una protagonista femminile che non incontra ostacoli, che non viene derisa, umiliata, o costantemente frenata perché donna in un mondo di uomini.
È anche rassicurante non vedere gli uomini minacciare ma, al contrario, supportare il percorso di una donna.
Quindi Elizabeth Harmon è il personaggio femminista del 2020? Ecco, ne riparlerei.
Beth è prima di tutto la più brava. La più intelligente, la più scaltra, la più risoluta. È anche la più bella, la più elegante, la più sensuale. Beth è di più in tutto.
Se i consigli degli uomini sono fondamentali e influiscono nel suo percorso verso la vittoria, ogni figura femminile intorno a Beth è in svantaggio:
chiuse in matrimoni asfissianti, casalinghe tristi e miserabili, ammiratrici che lodano Beth per essere liquidate da quest’ultima in un battito di ciglia.
Quando Beth incontra una modella parigina, questa le riferisce che non può essere come loro,
perché le modelle (o le ragazze di Parigi, in generale) sono tutte stupide e galline, mentre lei, Beth, ha qualcosa in più. È diversa, e per questo vince.
Tutto questo ha anche un nome: si chiama sindrome dell’ape regina.

Il termine “queen bee syndrome” proviene da alcuni studi dell’Università del Michigan del 1970.
Stando alle loro ricerche, incluse nel pezzo Psicology Today del 1974,
alcune donne che si trovavano ad operare in ruoli o contesti stereotipicamente riconducibili alla figura maschile,
attuavano comportamenti tossici e opprimenti verso le altre colleghe in posizioni simili.
Nel 2010 il Workplace Bullying Institute ha notato come le bulle riversano 80% dei loro abusi sulle altre ragazze. Nel 2011 su 1000 donne lavoratrici almeno il 95% ha dichirarato di essere stata sottostimata da un’altra donna ad un certo punto della sua carriera.
Come citato da Flora Ciccarelli,
la psicologa Chiara Volpato nel suo saggio “Psicologia del Maschilismo”,
stando ad uno studio condotto nel 2004 in facoltà scientifiche italiane e olandesi, ha parlato di “professoresse, che attraverso faticose strategia di mobilità sociale erano riuscite a entrare nel roccaforte maschile,
lo avevano fatto ponendosi come eccezioni, dissociandosi dall’universo femminile e accettando la visione stereotipata delle altre donne”.
Volente o nolente, per sette episodi The Queen’s Gambit sembra riassumere la sua protagonista con una frase: you’re not like other girls.
È una frase che i ragazzi, specialmente ai primi appuntamenti, amano ripetere alle ragazze, per farle un complimento e automaticamente screditare tutte le “altre”.
In The Queen’s Gambit una frase del genere è messa in bocca ad un personaggio femminile, ma cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia.

Alla regia e scrittura di The Queen’s Gambit c’è Scott Frank:
se da una parte ci mostra una donna risoluta e determinata a vincere in una realtà dominata dagli uomini,
la sua protagonista sembra anche frutto della sua fantasia maschile, delle sue percezioni su ciò che rende o meno una donna di successo,
e come per esserlo debba per forza seguire gli uomini e distinguersi da tutte le altre.
Il problema non è tanto che Beth sia una donna fredda, distaccata,
e pragmatica (ripetiamolo: l’emotività non è prerogativa femminile) quanto che non riusciamo a percepire nulla più oltre la sua ossessione per la vittoria.
I suoi problemi di tossicodipendenza e alcolismo vengono liquidati in tre minuti calcolati,
il suo mondo interiore, i traumi d’infanzia restano totalmente archiviati a favore di una strada praticamente spianata.
Beth spesso è sensuale, ma senza una ragione precisa ai fini del suo personaggio.
Certo, un’eroina può essere anche smaccatamente provocante senza nulla togliere alla sua intelligenza.
Ma quella di Beth è una sensualità del tutto inconsapevole,
di cui non ha controllo, che sembra esserle stata cucita addosso da qualcun altro per il piacere di chi guarda.

Non c’è nulla di male ad appassionarsi ad una storia come quella di The Queen’s Gambit
ma questo non ci impedisce di metterla in discussione e chiederci:
nel 2020, in un’epoca in cui il discorso sull’internazionalità del femminismo prende sempre più piede,
quanto può essere empowering la storia di un personaggio privilegiato, che nulla, nemmeno i propri demoni interiori scalfisce,
e dall’inizio alla fine vince senza la minima messa in discussione?
Se una protagonista non mi annoia è perché il suo viaggio verso la felicità non avviene in uno schiocco di dita:
è un viaggio di scoperta, nuove consapevolezze,
è una possibilità di riscatto in più verso una cultura dominante che tiene in disparte non solo le donne,
ma chiunque non corrisponde alla dicotomia del maschio bianco etero e cisdgender.
Ma nel viaggio di questa eroina non c’è scoperta:
Beth vince attenendosi alle regole della società dominante che la circonda, in una favola patriarcale che dimentica tutte le altre.
LEGGI ANCHE: Un tè con voi