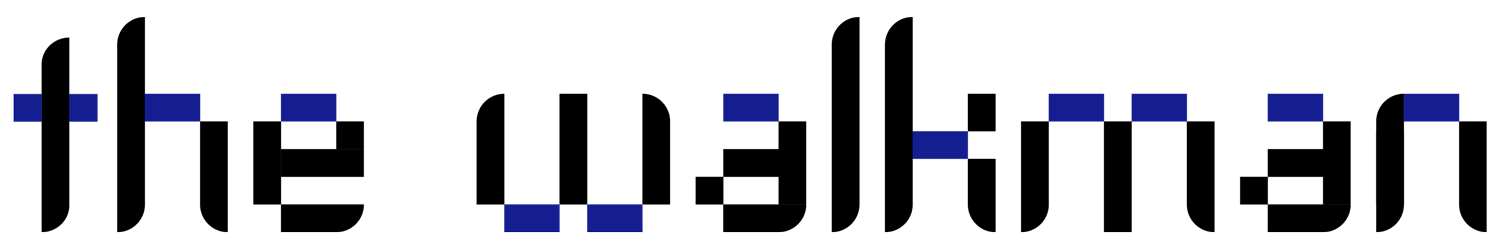Nomadi. Siamo sicuri che tutto quello che abbiamo sempre desiderato, immaginato, ambientato nella nostra mente, sia davvero ciò che vogliamo?
Li vogliamo davvero i nostri sogni, o abbiamo bisogno di desiderare per stare bene, per sentirci al sicuro? Ci sentiamo comodi nella nostra condizione, senza doverci muovere per realizzare quel che diciamo di ambire?
Quanto è comodo desiderare e non fare?
Potremmo desiderare vite mai avute per una vita intera, senza mai aver avuto la minima idea di cosa potesse significare davvero, vivere un’altra vita.
Un desiderio da tenere nel cassetto, ci rassicura. È lì, almeno lui. Sappiamo che esiste, esiste qualcosa di buono (?) nei nostri desideri, una piccola certezza in un’epoca che definiamo senza certezze ormai per moda.
Anche solo provare a realizzare i propri sogni, li rende reali, meno belli, toglie loro fascino. Mette in luce le difficoltà che potremmo incontrare nel realizzarli, i loro pro e i loro contro. Tutti i compromessi che non avremmo voluto scoprire. Il sogno vale il compromesso? Lo vogliamo davvero questo sogno?
E se tutto quello che abbiamo sempre pensato fosse il nostro posto, la nostra persona, il nostro lavoro ideale, il nostro futuro. Il nostro succo di frutta preferito, il nostro autore preferito, fosse semplicemente un’idea? Se fossimo nomadi?
Se dovesse cambiare tutto? E tutto quello in cui crediamo sparisse? Saremmo capaci di ricominciare? Di reinventarci? Di scegliere una vita nuova? Dove saremmo, chi saremmo? Che nomadi saremmo?
L’incertezza assume allora un nuovo aspetto, e non è detto sia negativo. Una parola grande come un macigno, che abbiamo fatto vessillo della nostra generazione. Un’idea che abbiamo rimarcato ancora di più con la Pandemia.
Giusto, la Pandemia. Siamo arrivati di nuovo qui, a menzionarla. Ormai possiamo considerarla parte integrante di questa realtà, come momento storico generatore di dinamiche inedite. Uno scenario imprevisto che ci ha costretto a stare nelle nostre città, nelle nostre case, con le persone con cui vivevamo in quel momento. Scoprendo di odiarle, di capirle meglio, di non amarle più. Ci siamo innamorati di loro. Rompendo le nostre certezze, gli schemi, le idee che avevamo di questi individui e delle nostre relazioni.
In così poco tempo abbiamo ribaltato il nostro quotidiano. Si tratta di sentimenti veri? Sembra sciocco chiederlo. Forse le relazioni nate dalla pandemia potrebbero essere le più vere, le più impetuose e sentite.
Diverse sono stati gli articoli pubblicati che hanno raccontato di persone che si trovavano in viaggio all’estero nel momento in cui sono state chiuse le frontiere a causa del Covid-19. In poche settimane, o mesi, lontani da casa, hanno cambiato vita per un breve periodo fino ad accorgersi di poterla stravolgere, rimanendo nei Paesi dove prima erano bloccati, o decidendo di vivere altrove. Nelle grandi città, o isolati sulle montagne, vivendo magari una vita opposta a quella precedente. Persone che in poco tempo hanno realizzato di voler cambiare tutto, casa, lavoro, prospettive.
A partire da Marzo 2020, ho avuto modo di osservare scelte improvvise di vita attraverso le finestre che affacciano nelle case degli altri. Non prendetemi per maniaca, lavoro al recupero dell’esistente a New York e ogni settimana sono sospesa su impalcature a cinquanta e oltre piani di altezza, per ispezionare le facciate delle architetture.
È un lavoro che richiede tempo, devo osservare piano per piano ed assicurarmi che non ci siano condizioni di azzardo. Avete mai sentito di persone colpite fatalmente da un pezzetto di mattone, mentre camminavano tranquille per strada? Io me ne sto appesa come Spiderman a controllare che nessun pezzetto di malta cada di sotto dalle facciate dei grattacieli di Manhattan. Faccio, anche, questo.
Prima del 2019, gli abitanti degli edifici si sporgevano dalle finestre per offrirmi acqua, succhi di frutta quando mi diceva bene. Nonne mi offrivano merende da condividere coi nipoti, io sulle loro finestre, loro nei salotti. Molta gente si affacciava per chiedermi quando sarebbero finiti i lavori correnti dell’edificio, altre per incazzarsi perché i lavori non finissero mai.
Ci sono palazzi su cui ho fatto su e giù per mesi, riconoscevo i salotti, gli stili, le persone.
Potevo raggruppare gli stili per quartieri, nettamente. È come uno status symbol, vivi a Upper East Side, questo è il modo in cui devi arredare casa. Vivi a Tribeca, Chinatown, Brooklyn, questo è il tuo stile. Punto.
Abitazioni identiche negli stessi palazzi, lo stesso modello di divano, la stessa location scelta per la libreria. La stessa, identica, lampada da terra. Per piani e piani, uno sopra l’altro. Pochi salotti si distinguevano, e lo facevano con estrema follia.
Poi, l’omologazione totale. Nelle camere da letto, potevo trovare le stesse letture. Gli stessi attrezzi ginnici, posizionati nello stesso modo. Tutto secondo rituali, regole, convenzioni che hanno saputo incanalare le nostre scelte. Siamo abitudinari, siamo branco. Adoriamo ancora i feticci, in particolare le lampade, ve lo dico.
Le case degli altri, tutte uguali dal sessantatreesimo piano al secondo, perché il primo è dei negozi. Le case piccole, e quelle grandi che non sanno essere gestite da queste masse omologate, che replicano lo stesso salotto tre volte nella stessa casa. Quanto dicono di noi le nostre case?
Quanto siamo le nostre case, ci rappresentano? Qual è la nostra identità? Ho pensato per mesi. Finché, a poco a poco, ho iniziato a vedere gli edifici svuotarsi. Non c’era più niente, nessun mobile, nessuno. E allora quelle persone che ho immaginato tutte uguali, descritte nei canoni dei loro arredi, adatti a quei quartieri, dove sono finite? Cosa sono diventate, e come hanno arredato le loro nuove case?
LEGGI ANCHE – TRE CONSIDERAZIONI SULL’ARCHITETTURA DURANTE L’ANNO DEL COVID
I managers degli edifici mi hanno confermato che con lo scoppio della Pandemia, famiglie intere hanno lasciato la città, per sempre. Hanno fatto i pacchi, dal giorno alla notte, e se ne sono andate.
Un virus, qualcosa di imprevisto e sconosciuto è stato capace di far prendere decisioni repentine, di cambiare vita. Credevo che queste case fossero state lasciate temporaneamente, scoprire che non fosse così mi ha lasciato sospesa.
L’abitudine è stata interrotta. Migliaia di persone hanno cambiato vita, altre sono in un limbo, ancora oggi non sanno dove saranno domani. Sono diventati nomadi a modo loro.
Di contro, ho letto recentemente su un articolo di Bloomberg Business Week, che a distanza di un anno, al contrario di quel che si pensa, sono più le persone che si sono trasferite a New York, di quelle che hanno lasciato la città.
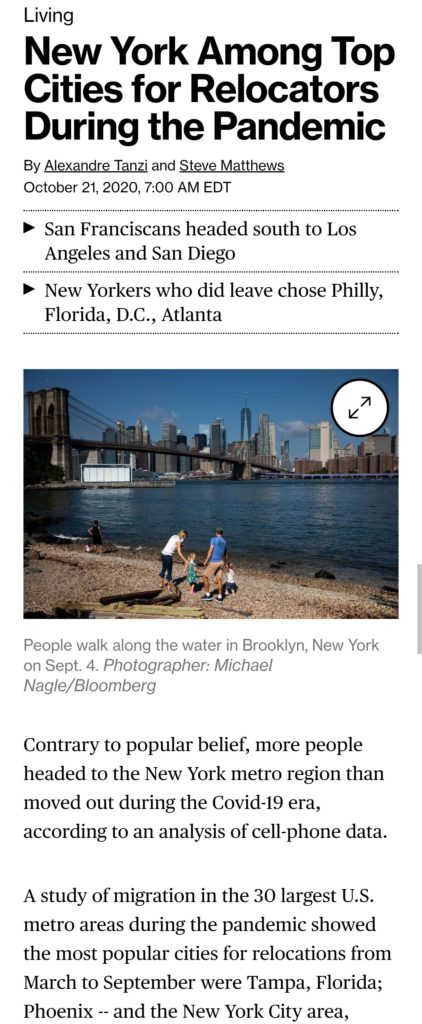
In molti sono stati attratti dal ribasso degli affitti causato dalla Pandemia, e hanno colto la loro occasione di poter finalmente vivere nella Grande Mela. Finalmente, anche loro oggi vivono in un francobollo quadrato di spazio nell’ombelico del mondo. Si sono buttati, hanno scoperto che qui non esistono armadi e hanno dovuto lasciare il loro bagaglio di vestiti, insieme a tante altre piccole certezze e conforti.
Chi è andato via, chi è arrivato. Qualcuno in reazione a un momento inaspettato ha cambiato vita, di colpo.
Tante storie, frammenti di un nuovo nomadismo, un nomadismo di reazione in una generazione frammentaria che da tempo ha già saputo sperimentare il vagare digitale, lo scollamento degli affetti, le relazioni con le emozioni. Quelli che hanno cambiato quattro lavori in un anno, quelli fluidi, che imparano nuove arti, che fanno tutto e si reinventano. La generazione Erasmus, e quella di ogni crisi possibile, fino a quella di identità. Eppure una generazione coraggiosa, capace di andare. Siamo nomadi e non lo sappiamo?
Forse, a prescindere dall’ossessione per gli stessi arredi e per ridicoli rituali, siamo tutti nomadi e non lo sappiamo. Basterebbe solo pensarlo per un secondo, ed avremmo già cambiato vita.
LEGGI ANCHE – NOMADI DIGITALI, LA STORIA DI GIORDANO E FLAVIO