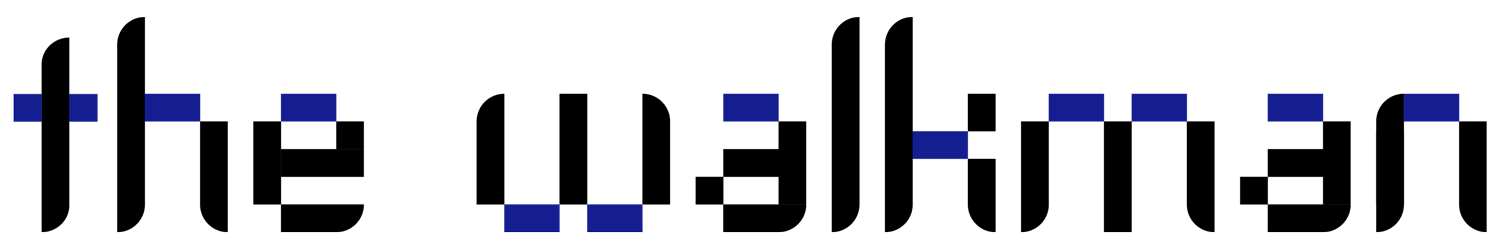Sono stata prigioniera della mia testa per anni, con le mani sudate e le gambe che tremavano correvo e pensavo che non avrei mai corso più della mia paura.
Gli attacchi di panico esistono ma come ogni cosa che arriva se ne va, basta trovare qualcuno disposto ad aiutarci.
Pensavo che il passo più difficile fosse ammettere a me stessa di avere un problema e di non saperlo risolvere. Ma mi sbagliavo. Il peggio è arrivato il giorno in cui ho deciso di andare al consultorio: per motivi economici, per una smodata fiducia nelle strutture pubbliche, perché ero fermamente convinta che le persone aiutassero solo per il piacere di aiutare e non perché la tua ora valesse 70 euro (senza fattura).
LEGGI ANCHE: Sono stata insieme a una persona che non esiste
“Il primo giorno ti sottoporremo ad un test.”
Il solo fatto che i miei attacchi di panico, le mie paure e le mie lacrime dovessero essere giudicate da 5 fogli di carta fronte-retro non mi era piaciuto neanche un po’. Continuavo però a ripetermi che le persone davanti a me avessero studiato per questo, che era arrivato il momento di farmi aiutare, di smetterla di rimanere da sola in un letto che era sempre disfatto ormai da mesi.
Dal test emerse poco e niente, non avevo nulla, o meglio, mi dissero che ero refrattaria alla terapia. I mesi passano, le psicologhe cambiano. Ne ho conosciute quattro. Età diverse, approcci diversi, nessun miglioramento.
La colpa però era sempre la mia.
Era colpa mia quando non riuscivo a parlare perché piangevo troppo, colpa mia quando dicevo di non voler portare foto dei mie famigliari, colpa mia quando ho chiesto dopo 8 mesi di cambiare psicologa perché stavo sempre peggio, ma soprattutto colpa mia quando ho detto che non volevo vedere uno psichiatra.“Ti fissiamo un appuntamento con lui che ti prescriverà dei medicinali”. Nella mia testa il pensiero era solo uno: quanto sto male perché l’unica soluzione per me sia prendere delle pillole? Ho sempre avuto un rapporto difficile con le medicine, io che curo tutto con una bustina di Oki. Mi facevano paura, mi facevano sentire ancora più malata.
Perché gli attacchi di panico in fondo sono questo. Sono una malattia. Una malattia che si prende tutto, anche la tua forza di combatterla.
Nel frattempo la mia vita si era fermata: primo anno fuori corso all’università, amicizie e uscite ridotte, non avevo più interessi, non cantavo, non suonavo, non dipingevo. Non avevo più voglia. Non avevo più niente.
LEGGI ANCHE: In certi casi lasciar perdere può salvarvi la vita
Non avevo più una vita.
I mesi sono diventati anni. Guardavo le persone fare cose semplici, cose che quando stai bene sembrano così normali: fare la spesa, andare a prendere un caffè al bar, guidare la tua macchina. Uscire. Uscire da una casa che era diventata allo stesso tempo il luogo più sicuro e la prigione più grande che c’è. Poi, le quattro psicologhe un giorno mi accompagnarono gentilmente alla porta: “hai bisogno di un uomo che ti segua”. “Dovresti andare in analisi”. “Dovresti chiarirti le idee”. “Se vuoi ti lasciamo il numero di uno bravo”. Che suona un po’ come una battuta. Ma chi è questo? Non ho voluto saperlo, non avrei accettato neanche una sigaretta da loro, io che ho le mani che puzzano sempre di fumo.
Ero di nuovo sola.
Ero di nuovo a casa.
Quante cose mi stavo perdendo? Quando tornerò a stare bene? Soprattutto, tornerò a stare bene? L’attacco di panico, quando arriva, dura per un tempo piccolissimo ma lascia un vuoto gigantesco, ed è tutto un vivere nel terrore che ritorni. Ti costringe a convivere con la paura, una convivenza a cui però non riesci ad abituarti mai. Ci sono momenti in cui non vedi più la tua vita, in cui non accetti che possa essere per sempre così, perché una vita non può essere così e ti trascini in un abisso.
La mia testa mi ha portato così giù che arrivavo a chiedermi quanto mi ci sarebbe voluto per tornare in me. Per tornare ad avere delle prospettive, delle ambizioni o anche solo per poter dire domani andrà meglio. Avrei pagato per un giorno diverso da quello precedente. E mi vergognavo, come se fosse una cosa da nascondere, una cosa che non sei normale se stai così, non puoi uscire se stai così.Non puoi dire che stai così. Ero diventata la più abile delle bugiarde, inventavo scuse, giustificazioni, assurde teorie per non uscire, per non rincontrare la paura, che tanto mi avrebbe trovato anche nel mio letto.
Ero caduta in un burrone e non mi restava che toccare il fondo.
Un fondo che non ha esitato ad arrivare quando mia madre, colonna portante della mia vita, risoluta donna del sud ma dalla lacrima facile, mi portò in braccio a fare un giro nel parco. Ero di nuovo la sua piccola bambina, che aveva bisogno di lei, ancora. Che piangeva e implorava di tornare a casa. Pensavo di aver superato quella fase della vita e invece no. Ero paralizzata, convinta che non avrei saputo fare un altro passo. Stringevo la sua mano così forte da far male, ancora. Mi chiedevo quanto ancora sarebbe durata quella tortura, perché proprio mia madre mi stesse facendo questo. Volevo solo andare a casa e lei continuava a starsene seduta su quella maledetta panchina.
In quel momento mi chiedevo se non vedesse quanto stessi male, perché non mi riportava a casa? Adesso invece mi chiedo dove abbia trovato la forza di guardarmi stare male e stare ferma ad aspettare. Arrivarono anche gli schiaffi di una madre distrutta, distrutta da me. Perché quando stai male diventi egoista, non ti rendi conto che insieme a te c’è sempre qualcun altro che soffre con te. Ed era lei. E allora cominciai a farlo per lei. Il giorno dopo avevo uno scopo: farla felice.
“Mamma io esco”.
Contavo i passi che giorno dopo giorno da dieci diventavano cento e poi mille e poi ero fuori dal mio quartiere. Ero da un nuovo psicologo e pagavo, pagavo il suo tempo, il mio tempo, i suoi consigli, le mie parole, le mie lacrime le sue rassicurazioni. “Sono solo attacchi di panico,come sono arrivati se ne andranno, sei forte Eleonora, insieme ce la faremo”.
Insieme.
Volevo essere solo capita e lui l’aveva fatto. Mi aveva insegnato a camminare tra le mie paure e a vedere cosa c’era dietro. E c’ero sempre io, che aspettavo solo di ricominciare. Niente pillole, niente foto, niente colpe. Tante lacrime, tanti abbracci, tante parole.
Sono bastati quattro mesi. Quattro come loro, ma questi erano veri.
Ed eccomi qui, a scrivere di quando sono stata male, adesso che faccio la spesa, prendo il caffè al bar e guido la mia macchina. Ed ogni giorno mi stupisco di quanto sia bella l’aria fredda di Gennaio quando esci la mattina, la pioggia all’improvviso quando non hai l’ombrello e corri, le risate rumorose degli amici ritrovati ma soprattutto il sospiro mentre chiudi la porta di casa e pensi: oggi sono uscita.